E piove pure, per non farsi mancare niente. In compenso, è arrivato il momento di smaltire qualche film accumulato nelle settimane passate; al solito, si tratta di roba indipendente e a basso costo a cui dare un po’ di visibilità nel mio piccolo. Quattro piccole sorprese, residui di ciò che mi è capitato di vedere a ottobre, che spero possano allietare le vostre serate novembrine, mentre ci avviamo a grandi passi verso la temutissima stagione natalizia, che Cthulhu, dammi la forza perché a me manca.
Cominciamo con un minuscolo film canadese che con l’inverno ci sta alla perfezione. Don’t Say its Name è un prodotto da budget quasi nullo, ed è un esperimento interessante perché il 90% del suo cast, tecnico e artistico, è composto da nativi, regista e attori protagonisti compresi. Racconta di un’agente della polizia indigena che deve indagare su una serie di omicidi avvenuti nella riserva, legati alla morte recente di un’attivista che voleva bloccare i lavori di trivellazione effettuati senza il permesso della comunità locale da una società mineraria. Si tratta di delitti molto efferati, con le vittime fatte a pezzi sotto gli testimoni che dicono di non aver visto niente, se non il sangue, e le ferite formarsi da sole.
Il film, diretto dall’esordiente Rueben Martell, è una piacevole variazione sul tema del wendigo, ma da un punto di vista interno alla mitologia, cosa che (correggetemi se sbaglio) non era mai stata fatta fino a ora. È anche un film con una marea di problemi, di recitazione e di ritmo in primis, e in seconda battuta di effetti speciali che, è impossibile ignorarlo, sono davvero molto poveri e sembrano usciti da una serie tv di metà anni ’90. Ma questo non deve distrarvi dall’importanza di Don’t Say its Name e dal fatto che, nonostante tutti i limiti del caso, è una buona storia, con dei personaggi con cui si entra subito in sintonia, e con un cuore politico a cui è doveroso rendere i giusti meriti. Bisogna sperare che progetti di questo tipo abbiano successo e si diffondano tra il pubblico col passaparola, perché ciò potrebbe portare un regista come Martell ad avere più soldi per un eventuale opera seconda.
Con tutti i distinguo del caso, e fatte le debite proporzioni, mi ha ricordato l’ultimo Candyman di Nia DaCosta, e non dico altro per non rovinarvi la visione.
Passiamo a un B movie molto più tradizionale e con tanto sangue. Siamo dalle parti della commedia splatter e caciarona, priva di pretese e tutta divertimento disimpegnato: Bloody Hell, diretto da Alister Grierson, è il film che risponde alla domanda: “Cosa farebbe Rambo se si trovasse calato in un survival horror coi bifolchi?”
La risposta è: un gran macello.
Rex è un militare in congedo che sventa da solo una rapina in banca. Purtroppo si fa prendere la mano e un’impiegata perde la vita, così Rex viene condannato e si fa 8 anni di prigione. Quando esce, non avendo nulla ad aspettarlo, decide di andarsene in Finlandia per cominciare una nuova vita. Il motivo per cui sceglie proprio la Finlandia come meta, è una roba che dovete vedere con i vostri occhi. Il poveraccio non fa neanche in tempo ad arrivare all’aeroporto, che lo narcotizzano e lo rapiscono.
Si risveglia nello scantinato di una casa isolata, legato al soffitto e senza una gamba, vittima di una famiglia con figlio maggiore deforme e cannibale. Riuscirà a fuggire e, allo stesso tempo, a conquistare il cuore della figlia minore dei redneck finlandesi, a cui i metodi dei genitori risultano particolarmente indigesti?
Intendiamoci, Bloody Hell è un filmetto, anzi, è un filmaccio vero e proprio, ma ha dei picchi di assurdo che lo rendono piacevolmente bizzarro. Il personaggio principale è uno sbruffone smargiasso da action DTV, che parla con una versione ancora più caricaturale di se stesso e riesce a stento a contenere i propri impulsi violenti. Dura poco, è ben diretto e, soprattutto, coloratissimo, e ti lascia con un bel sorriso sulle labbra quando iniziano a scorrere i titoli di coda. A volte, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere a un’altra settimana.
Rimaniamo in zona commedia nera, ma in salsa found footage, per I Blame Society, trionfo mumblecore scritto, diretto e interpretato da Gillian Wallace Horvat. Qui ci vuole subito un’avvertenza: se non sopportate le satire metacinematografiche ad alto tasso di ironia autoreferenziale, in cui tutti gli attori interpretano delle versioni appena un po’ più sopra le righe di loro stessi, e il sottobosco indie di Hollywood si parla addosso per 84 minuti, magari, ecco, dovete stare lontani qualche centinaio di chilometri dal film. Se, al contrario, questo tipo di cose ancora vi strappano un sorriso, dategli un’occasione, perché sì, è una satira meta che tende un po’ a parlarsi addosso, ma è anche un film incredibilmente intelligente, capace di dire tante cose sul ruolo delle donne in un mondo del cinema che sta solo facendo finta di cambiare e dove i meccanismi del potere reale sono sempre e comunque in mano agli uomini.
Gillian è una regista in crisi creativa, che sta quasi per decidere di smetterla coi film e andare a studiare legge. Le torna in mente un vecchio progetto di un documentario, abbandonato qualche anno prima: dei suoi amici le avevano detto che sarebbe stata una perfetta assassina, e lei aveva preso alla lettera il “complimento”, e aveva deciso di girare un film in cui mettere alla prova la sua capacità di ammazzare la gente. La vicenda non aveva avuto alcun seguito, ma ora diventa una sorta di ultima spiaggia per il destino da regista di Gillian.
Che infatti si dedica al progetto con grande serietà, forse persino troppa.
I Blame Society è un film che comincia in modo molto leggero, per poi avvitarsi in una spirale di oscurità sempre più fitta, e più si avvita, più l’umorismo deviato e caustico funziona. Non è certamente una passeggiatina nel parco, eppure vi assicuro che vi ritroverete, nell’ultima sequenza, ad alzarvi in piedi e applaudire. Per i nostalgici di quanto Ti West cianciava di documentari impegnati prima di prendersi un colpo di balestra in fronte.
La mazzata neozelandese ce la teniamo in coda. Si dice tanto della durezza del cinema australiano, ma pure la Nuova Zelanda te la raccomando. Coming Home in the Dark, di James Ashcroft, rischia di prendersi la palma come film più desolato e freddo dell’anno, quindi maneggiatelo con una certa cura, non guardatelo se siete depressi, non guardatelo se cercate un film semplice e in cui ci sia poco da elaborare o digerire. Ovviamente, è il mio favorito del gruppo di oggi.
C’è un’allegra famigliola in gita da qualche parte in un luogo isolatissimo e lontanissimo dalla civiltà. Mamma, papà e due figli adolescenti vengono avvicinati da una coppia di vagabondi che li prende in ostaggio e li obbliga a un lungo viaggio in macchina verso meta ignota.
Per la prima mezz’ora, il film dà quasi l’impressione di essere un remake neozelandese di Funny Games: l’atmosfera e le vibrazioni sono più o meno le stesse. I due criminali sono spietati e privi di qualunque forma di empatia verso gli sventurati che hanno incrociato il loro cammino, e c’è una sequenza che mi ha fatta letteralmente gridare da sola dentro casa.
Ma poi, la faccenda prende un’altra piega, forse anche peggiore. Perché forse c’è qualcosa nel passato del padre di famiglia che ha risvegliato la rabbia degli aggressori, e allora il film si trasforma in una storia di vendetta, in un apologo morale sulle origini del male nelle persone, e si viene a creare una fortissimi ambiguità sui ruoli, su chi siano le vittime, chi i carnefici.
Altro non vi dico, tranne che Daniel Gillies interpreta uno dei villain più terribili e spaventosi a memoria d’uomo, e che Coming Home in the Dark vi lascerà qualche ferita da rimarginare, quindi ribadisco il consiglio: fate attenzione e guardatelo solo se ve la sentite.














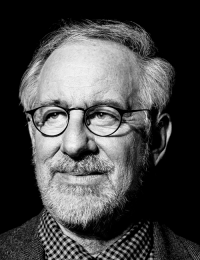






Grazie Lucia, i due centrali li ho visti e mi sono piaciuti, il primo e il quarto non li conoscono e mi intrigano molto. A vederli affiancati mi rendo conto solo ora che sia Bloody Hell che I Blame Society hanno la peculiarità di avere un/una protagonista con turbe psichiche dovute alla loro esperienza di vita, anche se i due film utilizzano questo elemento in maniera molto diversa.
Diciamo che Bloody Hell la butta parecchio in farsa, questione della malattia mentale del protagonista compresa, mentre I Blame Society ci costruisce un discorso sopra.
Bloody hell l’ho visto quasi per caso, sono stato solleticato dalla locandina (come quando ci si faceva convincere dalle copertine dei dischi) e non mi divertivo così tanto da secoli, che meraviglia! sbruffonaggine alla Ash, sangue, idiozie e regia pure mica male!
Recupero quanto prima Don’t Say It’s Name e Coming Home In The Dark (quando si tratta di neozelandesi e australiani si va quasi sempre sul sicuro).
Sì, è un film che davvero ti fa passare 90 minuti in totale allegria e poi sei contento di averlo visto. ❤